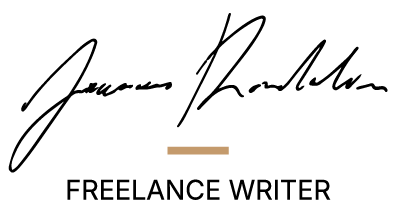Giorgio Terruzzi è l’iconico giornalista che da decenni si occupa di motori, in ispecie di Formala Uno. Cresciuto nella “Milano da bere” degli anni Ottanta, ne ha assimilato lo spirito, la sagacia, la sottile e pungente elitaria ironia che si respirava in quel decennio così edonistico, ma allo stesso tempo così guasone e sincero. La sua preparazione, la sua cultura, il suo essere una persona vera, rendono il suo modo di fare giornalismo un esempio che andrebbe preservato per le generazioni a venire. Persona disponibile, garbata e preparata, ci ha rilasciato questa interessante intervista a margine di una sua conferenza tenuta qualche giorno fa a Borgo a Buggiano, paese nell’entroterra toscano.
Tu hai studiato al DAMS di Bologna. Quegli anni universitari bolognesi, prima di entrare nel mondo del giornalismo, immagino siano stati particolarmente vivaci, essendo un decennio, quello degli anni Settanta, abbastanza turbolento.
Mi sono iscritto nel 1977 e ho terminato il mio percorso di studi nel 1980. Erano anni durissimi perché c’era Lotta Armata e la situazione era di grande tensione. Io sono stato salvato da un pool di professori strepitosi. Scelsi questa facoltà già con l’idea di scrivere e di occuparmi di comunicazione. Ho avuto docenti quali Umberto Eco, Gianni Celati che insegnava inglese, Paolo Fabbri comunicazione di massa, Piero Camporesi italiano, Luciano Nanni estetica, Luigi Squarzina regia… un pool di professori di grande qualità. Questo mi ha salvato, perché non potevo star lì a cazzeggiare, dovevo studiare e finire. Mi ha salvato anche da certe derive di violenza, che erano vicinissime, e oltretutto non ho mai pensato che sia possibile offendere fisicamente una persona che la pensa diversamente da me. Era una situazione di grandissima tensione che cambiò dopo il sequestro e la morte di Aldo Moro con un giro di vite intellettualistico fin troppo rilevante. Sono stati anni importanti, perché molti di questi professori avevano una visione laterale. Erano veramente anni di formazione dentro un periodo che a sua volta è cambiato moltissimo. Conoscevo molte persone, anche amici miei, che pensavano che ci potesse essere una concreta possibilità eversiva. Anche se era un’utopia, loro ci pensavano seriamente. Dopodiché c’è stata una virata sull’eroina che ha falcidiano molti giovani. Erano anni difficili. Io per fortuna avevo una bussola, avevo bisogno di finire e ero molto interessato alle cose che studiavo, per cui ho trovato una corrispondenza in un sacco di validi insegnanti, e ciò è stato profondamente formativo. Poi ho cominciato subito a lavorare col Beppe Viola, per cui ancora prima di discutere la tesi, avevo già iniziato a lavorare. Ho avuto molta fortuna, in un tempo in cui fare questo mestiere era molto più semplice. Avevi la possibilità di farlo molto di più rispetto ad oggi. Adesso il giornalista è un mestiere quasi finito. Lo dico pensando ai ragazzi che mi scrivono dicendomi che vogliono fare i giornalisti; devi avere alle spalle una famiglia che ti sostiene per molto tempo, perché sennò fai fatica a guadagnare uno stipendio. È molto diverso da allora.
La Milano di inizio anni Ottanta, per un giovane come te che muoveva i primi passi nel mondo del giornalismo, che ambiente era?
Milano è la città dei giornali. Io sono stato fortunato perché avevo Beppe Viola che è stato come un babbo per me.
Prematuramente scomparso poco più che quarantenne.
Aveva solo quarantadue anni. è morto troppo presto. Lui aveva quattro figlie femmine e a me, di fatto, mi ha adottato. Io avevo vent’anni. Lui era molto serio e severo sul lavoro, ma poi la sera mi portava in giro con lui e girare la Milano con lui era come andare in un parco giochi. C’era dentro il cabaret, le scommesse all’ippodromo, San Siro, il bar Gattullo e in più una fauna di personaggi incredibili. Era veramente una goduria. È stato un tempo formativo anche quello. Milano poi è cambiata e quelli erano gli ultimi fuochi. C’era un’energia in quegli anni lì ancora molto forte, una sorta di trasversalità per cui potevi incontrare grandi intellettuali, grandi designer e malavitosi o gente che non si capiva bene cosa facesse, o saltimbanchi [ride]. C’era una situazione molto promiscua, ma promiscua nell’energia, nella vivacità. È stato un bel tempo quello, nonostante la morte di Beppe che fu un dolore e un dispiacere fortissimo.
Il bar, all’epoca, era vissuto come fosse una seconda casa.
Molti bar erano seconde case. C’erano i tavoli da biliardo dove si giocava spesso, c’era un’abitudine a trovarsi lì senza appuntamento. C’era la consuetudine a trattare questo luogo di condivisione come una zona di conforto, dove parlavi di politica o di cazzi tuoi. Non è come adesso. Adesso è un tempo di solitudine.
Sostengo che il bancone del bar è il posto più democratico del mondo. Al bancone non si fa distinzione di censo, classe sociale o posizione lavorativa. Si è tutti uguali al cospetto del barista.
Certo! C’è una cosa in più: io ho avuto sempre rapporti col mondo del rugby, col mio club, che a sua volta è un posto dove condividi tutto. Non era soltanto il bar, ma c’era un’abitudine a condividere la tua vita, gli affetti, le gioie e i dolori con gli altri. Era molto più facile condividere le cose rispetto all’oggi. E c’era molto meno fuffa. C’era più individualità, più sé, più interiorità trasferita agli altri. Più chi sono, chi sei, mia moglie, i problemi, i figli… parlavi delle cose che erano veramente rilevanti. Adesso mi pare più difficile che succeda.
Il mestiere del giornalista è cambiato profondamente. Quali sono stati, per sommi capi, i cambiamenti più significativi di questo lavoro?
Ho tre figlie e vedo che è cambiato tutto. Le generazioni dei giovani di oggi sono generazioni che hanno una cultura sul vedere, non sul leggere. È un po’ diverso. Io non vedo nessun ragazzo con in mano un giornale. Con in più un incremento di velocità e di mordi e fuggi. Dai uno sguardo a un titolo o a due righe al massimo e non leggi l’articolo. Questo ha determinato una serie di cambiamenti, una serie di complicanze economiche. Io lavoro per il «Corriere della Sera» da molti anni e tu lo trovi tutti i giorni in ogni paese d’Italia. È uno sforzo logistico enorme, nonostante si stampi in più posti. In ogni piccola località trovi il «Corriere» portato lì ogni notte. Una volta ne portavi cinquanta copie e ne vendevi quarantotto, adesso ne porti una decina e ne vendi due. È cambiato tutto. È cambiata la fruizione, il modo di guardare il mondo, il modo di sapere le cose del mondo, perché vedi tutto. Hai notizie in circolo ovunque. La narrazione è il fascino di questo mestiere, ma è il fascino anche del lettore che scopre, attraverso una narrazione, un luogo, una storia. Adesso hai tutto e subito. Io che ho fatto tanti anni di Formula Uno, una volta si parlava con i piloti, andavi a cena con loro. Adesso questi postano sui social e non è uguale. Io non sono uno che dice che ai miei tempi era meglio, però era diverso. Se faccio un post dove dico che sono a Bangkok, invece sono a casa, per tutti sono a Bangkok e non parlo con te, ma ti comunico che. È tutto diverso. Il fatto poi di non leggere non migliora il linguaggio di chi scrive, non c’è niente da fare. Non c’entra un cazzo essere boomer e non è un problema generazionale, ma per migliorare il proprio linguaggio, e quindi la propria qualità di scrittura, si deve leggere. Probabilmente è una tematica che riguarda noi che siamo più grandi, mentre forse ai giovani non gliene frega niente di questo argomento, perché è diversa la fruizione. È inutile star qui a menarla, i cambiamenti sono sotto gli occhi di tutti.
Gli ultimi anni, in particolare dal 2020 in avanti, abbiamo visto che il mondo del giornalismo e della comunicazione ha attraversato un momento delicato. L’informazione è stata, a volte, non aperta a un dibattito ampio su macro tematiche che, giocoforza, hanno coinvolto tutta la popolazione. Penso alla pandemia, alla guerra in Ucraina e via discorrendo. Il tutto è sempre avvolto da una cappa di politicamente corretto.
Questo è un altro tema importante. C’è un conformismo che non ho mai visto.
Il cosiddetto politically correct ha pervaso ogni aspetto del giornalismo.
È una questione culturale. È una cifra di questo tempo. Ripeto, mai visto un conformismo così. Io ho una malattia che si chiama morbo di Crohn, di cui nessuno sa un cazzo. Ho un medico che non è affatto un no vax, ma che durante la pandemia mi ha detto: «Giorgio, aspetta un attimo, perché abbiamo avuto dei riscontri un po’ complessi sul vaccino». Non potevo parlarne. Se tu parlavi con i tuoi amici di questa cosa qua e gli dicevi: «No, io ancora non mi sono vaccinato», ti etichettavano come un no vax che spaccava le vetrine. E non è così. Oppure se tu dicevi all’inizio del conflitto russo-ucraino: «Ma certo che anche Zelens’kyj però…, eri immediatamente un putiniano convinto. Per non parlare del tema maschilismo-donne. Io ho tre figlie femmine, se sbagli un verbo – e sanno benissimo come sono io e che non me ne frega niente – sei una merda. Poi alla sera guardiamo tutti le veline e nessuno dice niente. Questo politically correct ha rotto i coglioni, è una sorta di convenzione che non è mai messa in discussione, non ha mai dentro un momento di verità. Tu puoi discutere su certi aspetti di un tema, senza per forza diventare immediatamente l’opposto di chi sostiene il contrario. C’è sempre una zona grigia. Questo c’è anche nel giornalismo. Se io dico: «Quel personaggio lì non mi convince per questa cosa», non sto dicendo che è un disgraziato, un bandito. No. Sto discutendo su un tema. Poi il web rilancia quello. Ho molte esperienze di interviste a persone che conosco, che proteggo io, perché se io faccio un’intervista a te e mi dici che sei fidanzato con la figlia del tuo vicino di casa, è la figlia del tuo vicino di casa che determina il titolo del rilancio sul web. Cosa che non c’entra niente con l’intervista che faccio a te. Questa cosa determina tutta una serie di diffidenze, anche giustificate, perché c’è una sorta di speculazione continua sul clamore. È così.
Bisogna per forza adattarsi a questi cambiamenti?
Tu ti adatti, io ho sessantasette anni e posso anche fregarmene.
Faccio fatica anche io a concepire questa situazione. Detto questo, il mondo dei motori è stato il tuo pane quotidiano per anni e tutt’ora lo è. Prima di passare alla Formula Uno, ci sono due manifestazioni molto affascinanti quali la Parigi – Dakar e il campionato del mondo Rally. Due tipologie di corse molto impegnative e altamente spettacolari.
Ho fatto una Dakar, un Rally dei Faroni e un po’ di rally. Il mondo dei rally è un mondo bellissimo, anche perché è più lontano dai media. È più difficile da seguire, perché non è un circuito e ha tutta una serie di complicanze, ma conserva di più un’atmosfera e una sua genuinità. La Parigi – Dakar, che adesso è un’altra cosa, era una vera follia. Io ho avuto sempre un grande affetto per Fabrizio Meoni [motociclista italiano, NdA], morto vent’anni fa oramai. Ho dato una mano al documentario [Nel nome del padre, NdA] che ha fatto recentemente suo figlio. Tante tragedie alla Dakar. Era una roba inumana, molto faticosa e molto pericolosa. Sono andato in macchina con Ari Vatanen, lui guidava una Peugeot, e anche se non hai la paura che hai quando vai in strada – perché in mezzo al deserto non hai riferimenti come le case o i lampioni – però ti accorgi che quando vedi un sasso lungo in tuo percorso sulla sabbia, te lo ritrovi già sotto la vettura. È molto pericoloso. Gli anni d’oro della Dakar erano un tempo in cui l’esplorazione del mondo era ancora in parte da scoprire se vogliamo. Quando scoppiò la guerra del Golfo [1990, NdA] pensai che fosse la fine per la Parigi – Dakar perché il deserto adesso lo vedevi con la guerra e la questione cambia. Non più macchine, camion e moto che sfrecciano tra le dune desertiche per una gara, ma ora avevi l’idea che il circo fosse finito. È cambiato moltissimo il rapporto con l’ignoto, con l’esplorazione, con l’estremo. È stata una stagione, la Dakar, piena di morti, troppi secondo me.
Le gare motoristiche spesso sono scosse dalla morte improvvisa dei piloti, perché sono sport dove si va sempre al limite e oltre. Per un giornalista sportivo, che di fatto segue degli eventi che fanno parte dell’intrattenimento e del divertimento, quando ci si scontra improvvisamente con una morte in pista, come ci si sente?
Questo è stato il tema fondamentale del mio lavoro. Le gare automobilistiche non sono come il tennis o come il calcio. Hai a che fare con gente che può morire e qualche volta muore. Non ci pensi, perché vivi con questi qua, sei in giro sempre con loro e ti dimentichi. Invece ogni tanto ti arriva questo schiaffone qua. È un mondo molto interessante per me, lo è sempre stato. A me interessano le persone, non mi interessa la tecnica. E questa scelta di mettere in gioco la propria vita mi ha sempre incuriosito ed è un mistero, perché i piloti non ne parlano mai, perché sennò vanno a casa [ride]. È il tema dell’esistenza, del senso dell’esistenza, che è una tematica che ci riguarda tutti. Mi interessa moltissimo star dentro quella linea di confine che è fatta di coraggio, ma non solo, di talento, ma non solo, di avventatezza, ma non solo, di scelleratezza, ma non solo. È una zona di straordinario interesse, se sei interessato alle persone e a come funzionano le persone. Per intenderci è come avere a che fare con uno spettacolo di acrobati che non hanno la rete di protezione. Questo aspetto mi ha sempre colpito e mi ha anche ferito. È tutto ad alta intensità e anche se fai il giornalista, questa sensazione, questa esperienza ti prende e ti tira dentro.
Hai parlato di persone e allora ti chiedo se ci sono stati piloti che oltre ad essere grandi campioni in pista, sono stati anche un esempio, un modello di vita fuori dalle competizioni?
Gli esempi sono quelli che, pur sapendo fare tanto, pur avendo un grande talento, si alzano al mattino con la voglia sempre di migliorarsi. Mettono da parte quello che sanno fare bene, che è tanta roba, e s’impegnano a migliorare dove non sono bravi abbastanza. Se lo fa uno così lo posso fare anch’io, o no? È veramente un buon esempio. Tu, nel tuo lavoro, nelle tue giornate, dai il massimo o no? Tutto ciò è interessante, perché ti suggerisce di fare un po’ meglio. Ti mette un po’ di umiltà, cosa che tra giornalisti è difficile, perché è una categoria di montati. Prova a migliorare, prova a perseguire degli obiettivi. È molto bello tutto ciò e questo è quello che insegna lo sport.
Permettimi un paragone: visto che il calcio è diventato lo sport mainstream per eccellenza con i tanti cambiamenti di questi ultimi lustri, secondo te i calciatori hanno lo stesso valore etico e morale di atleti di altre discipline?
Io non mi occupo di sport minori, quindi del calcio non me ne frega niente. Non ho interesse per uno sport che tratta i simulatori come normali, che tratta gente che protesta con l’arbitro come normale, oppure gli allenatori che fanno continuamente queste scene a bordo campo inutili. Aggiungo anche che i rapporti tra alcuni uomini di calcio e gli ultras mi fanno schifo. È uno sport che non si modernizza. Se un presidente fosse veramente evoluto, ogni suo giocatore che prende un’ammonizione per proteste dovrebbe pagare cinquecento mila euro di multa, vedrai poi che non succede più. Ognuno che simula, cento mila euro di multa. Ma purtroppo ciò non accade, siamo sempre lì con la gente che parla, che protesta… che palle!
È una bellissima risposta, che peraltro condivido in pieno. Torniamo in ambito motoristico. Donne e motori sono stati sempre un binomio imprescindibile. È così a tutt’oggi credo.
I piloti hanno il fascino dell’eroe, cazzo! Il fascino di uno che fa cose eccezionali, ma non solo i piloti. Tutti i grandi atleti, e non solo, hanno delle gran belle ragazze di fianco. A differenza dei giornalisti che non le hanno, perché non possono, in quanto hanno delle facce da somari e lavorano mentre gli altri broccolano le ragazze [ride]!
Spesso in Formula Uno gli ordini di scuderia sono imprescindibili. Se un pilota lotta per il titolo il compagno di squadra a volte è costretto a lasciarlo passare avanti. Lo ricorda anche Riccardo Patrese nel suo libro «F1 backstage. Storie di uomini in corsa», dove tu sei co-autore.
Quando c’è in ballo un titolo le scuderie dettano gli ordini. È un po’ una regola. Non ci sono quasi mai delle ingiustizie a priori. A Patrese andò storta un po’ di volte, è vero, però gli andò storta con Nelson Piquet e Nigel Mansell, due fenomeni che in quel momento lì erano messi meglio di lui. Capita.
La famosa ruota di Eddie Irvine ai box nel 1999? Di fatto, per quell’errore, il ferrarista perse il titolo mondiale.
Questa storia è un libro. È una storia molto lunga e molto complessa. Però insomma, non possiamo discutere Michael Schumacher.
Le pagelle di Giorgio Terruzzi sono sempre un appuntamento immancabile per gli appassionati.
Le pagelline! Il diminutivo è importante, perché è una presa per il culo di quelli che le fanno sul serio. La Formula Uno è uno sport dove è difficile comprendere certe dinamiche. Non sai se un pilota che arriva sesto, con una macchina di quint’ordine, fa una prestazione di guida migliore di uno che vince con una macchina perfetta. Non lo sai, per cui non ha senso fare le pagelle e quindi faccio le pagelline. È un gioco ironico rispetto a uno sport dove è difficile capire certe questioni. Nel calcio se uno sbaglia uno stop lo vedi, è palese. Nel nuoto uno che arriva quarto è visibilmente andato più piano di quelli che hanno vinto. Nelle corse è più complicato.
Ci sono sport che godono di visibilità nelle reti mainstream televisive a corrente alternata. Ogni tanto spariscono. Penso ad esempio alla boxe. Oggi è difficile trovare un incontro in tv. Vista la tua carriera in Mediaset, come mai avvengono questi cambi di palinsesti?
È come il discorso che abbiamo fatto sul giornalismo. Non c’è più la boxe, ma ci sono un sacco di quei combattimenti dove si menano selvaggiamente. È stato scollinato un mondo. è come l’estremo; una volta c’era soltanto qualcosa, gli alpinisti per esempio, i piloti… adesso ci sono ragazzi che si buttano giù con la tuta alare da ogni montagna. Tutto è molto cambiato e appare quasi normale che il pugilato, come arte ottocentesca, sia soppiantato da altro, da un combattimento dove succede di tutto.
Ti ho fatto questo esempio, perché a volte i cosiddetti sport minori, fanno veramente fatica a ottenere visibilità e attenzione in televisione.
Ci sono alcuni sport che hanno una vita perenne. La scherma, ad esempio, è uno di quelli e non è cambiata tanto. L’atletica, grazie a Dio, non è cambiata tanto. Alcuni sport invece sono cambiati tanto.
Va da sé che in una disciplina sportiva quando emerge un campione come Alberto Tomba per lo sci o Valentino Rossi per le moto, ecco che i riflettori si accendono su quello sport.
Oggi c’è Sinner e se vai in un bar tutti parlano di tennis, come se facessero tre volée al giorno. Come quando ci fu Luna Rossa, l’imbarcazione che ci ha fatto sognare nell’America’s Cup. Ci sono dei cicli che sono legati ai campioni e il campione del tuo paese trascina il suo sport.
C’è un nuovo Giorgio Terruzzi oggi?
Spero di sì, ma pure meglio! Non mi considero niente di speciale. Ho avuto la fortuna di fare il mestiere che desideravo fare. Penso che ogni opportunità vada onorata, per cui mi faccio il culo ancora adesso, perché credo sia doveroso per fare in modo che le cose siano fatte bene. Credo che il successo nella vita sia quello di andare a letto sereni, come sostiene sempre un mio caro amico. Io mi sento in imbarazzo quando mi viene fatto un complimento, perché penso che faccio semplicemente il mio lavoro, che fanno in tanti, in campi diversi. Non c’è nulla di eccezionale. Spero che ci siano tanti ragazzi che abbiano l’opportunità di fare i giornalisti e che si facciamo il culo per farlo bene.
Grazie!
Grazie a te.
Borgo a Buggiano, 3 luglio 2025.